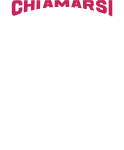Cresciuto nel vivaio del Cosenza, Stefano Fiore ha attraversato oltre quindici anni di calcio ad alti livelli, indossando le maglie – tra le altre – di Parma, Udinese, Lazio, Valencia, Fiorentina e Torino. Tra i protagonisti della Nazionale azzurra all’Europeo del 2000, Fiore ha conquistato diversi trofei, tra cui due Coppe UEFA con il Parma e due Coppe Italia, una con i crociati l’altra con i biancocelesti. In questa intervista rilasciata ai nostri microfoni, Fiore riapre il cassetto dei ricordi: dalla “Banda Mancini”, alla doppietta decisiva contro la Juve in Coppa Italia, passando per l’esperienza complicata con Ranieri al Valencia. La redazione di Chiamarsi Bomber lo ha intervistato sul suo trascorso con uno sguardo anche sull’attualità, tra la nuova Lazio targata Baroni e le prospettive future di Fiorentina e Torino.
Partiamo dalle origini. Dopo le giovanili al Cosenza approdi al Parma, dove Nevio Scala intravede in te qualcosa di speciale e ti fa debuttare in prima squadra. Che ricordi hai di quel giorno e della tua esperienza in Emilia?
“L’esordio è sempre un giorno particolare, bello, emozionante. Rimane nella memoria di tutti i giocatori che esordiscono in Serie A. È il sogno che diventa realtà. Il futuro è ancora tutto da scrivere, però essere lì è qualcosa di speciale, emozionante. Io ne ho un ricordo bellissimo, ma di tutta la mia esperienza a Parma. Per me è stata una seconda casa, perché arrivai con grandi aspettative e tanti punti interrogativi. Avevo appena 18 anni e avevo esordito l’anno prima in Serie B. Per me era qualcosa di molto grande. Poi il Parma, in quegli anni, aveva una squadra clamorosa, quindi per me era già tanto essere lì… Figuriamoci poi allenarmi tutti i giorni con loro ed esordire a Genova nel dicembre del ’94. Fu bellissimo. Quell’anno si completò in maniera straordinaria, perché riuscimmo a giocare la finale di Coppa UEFA a Milano contro la Juve, tra l’altro vincendo quella Coppa. Parma è stato l’inizio della mia storia calcistica, soprattutto in Serie A, ed è sicuramente tra i ricordi più belli che ho. La squadra era incredibile: da Buffon a Thuram, Cannavaro, Crespo, Chiesa… Parma era formidabile”.
Dopo una stagione in Serie B con il Chievo, ritrovi Alberto Malesani al Parma e vivi un’annata straordinaria: Coppa UEFA vinta nel ’99 con una squadra piena di campioni come Buffon, Thuram, Cannavaro, Crespo, Chiesa. Che gruppo era quello? Con chi avevi legato di più?
“Ricordo volentieri il rapporto che avevo con Gianfranco Zola, perché lui era un campionissimo. Arrivava dal Mondiale del ’94 insieme a tanti altri, come Minotti, Apolloni, Mussi, Benarrivo. Io, anche perché era il giocatore al quale mi ispiravo e dal quale volevo imparare, cercavo di osservarlo. Mi fermavo a guardarlo quando calciava le punizioni a fine allenamento. Il suo carattere, il fatto che fosse una persona molto alla mano e assolutamente disponibile, mi fece innamorare ancora di più, perché riuscivamo ad avere molto contatto, nonostante fra di noi ci fosse differenza non solo di età, ma soprattutto sportivamente parlando. Io iniziavo, e lui era già un fenomeno. Ho un ricordo bellissimo di lui in particolare. Però devo dire la verità: anche gli altri grandi giocatori che c’erano erano tutti prodighi di consigli”.
Poi arriva l’Udinese, dove diventi un giocatore completo anche grazie alla fiducia di De Canio, che ti rende titolare inamovibile. Che ambiente hai trovato in Friuli e quanto è stato importante per la tua crescita?
“Per me è stato fondamentale, perché giocare in quel Parma lì era complicato. Sgomitavo, ma facevo fatica ad emergere, perché i giocatori che c’erano lì erano veramente bravi e non era semplice far giocare un giovane al posto di quei campioni. Alla fine del ’99 avevo voglia di misurarmi per vedere se ero in grado di fare il titolare in Serie A e quando ci fu la possibilità di entrare nello scambio con l’Udinese accettai super volentieri, perché loro lavoravano molto bene con i giovani. Era la mia piazza ideale. Lì ho trovato un ambiente familiare, pieno di giovani talenti pronti a dimostrare di essere all’altezza della Serie A. Una società super competente, una famiglia, i Pozzo, che hanno scritto per certi versi la storia del nostro calcio, perché sono stati sempre un serbatoio incredibile di giovani italiani, ma anche di giovani stranieri, che venivano pescati in tutto il mondo e poi si rivelavano sempre giocatori straordinari. Per me è stata una fortuna, perché da lì ho cominciato a scrivere la mia storia in Serie A con due bellissimi campionati. Alla fine del primo raggiunsi la Nazionale, giocai l’Europeo del 2000. Se Parma è stata la mia seconda casa, Udine è stata l’esperienza che mi ha lanciato definitivamente”.
In Nazionale hai perso la finale di Euro 2000. Quell’Italia era davvero forte. Che ricordi hai?
“Ho cercato di rimuoverli… Quando parli di Euro 2000 non puoi non pensare a quell’epilogo. Probabilmente una delle Nazionali più forti di quegli anni, che avrebbe dovuto vincere… e non l’ha fatto. Questa è, a volte, la bellezza ma anche la crudeltà del calcio. Della finale ho un ricordo dolce e amaro. Siamo arrivati a pochissimi secondi dall’essere campioni d’Europa. E anche con merito, per quello che riguarda la finale. Dico sempre che abbiamo forse pagato un po’ la fortuna che avevamo avuto nella semifinale con l’Olanda. Giocammo una partita epica, in dieci per buona parte della gara, e con tante occasioni che l’Olanda non ha sfruttato. La Dea bendata, che ci era stata amica in quella partita, ci ha girato un po’ le spalle in finale. Però, per me — che ero entrato solo pochi mesi prima in Nazionale — pensare di giocare addirittura la finale ed essere a pochi secondi dal diventare campione d’Europa… ha mitigato, almeno in parte, l’amarezza per non aver vinto quell’Europeo”.
Poi la Lazio, che tu stesso hai definito “L’apice della tua carriera”. Cosa ha rappresentato per te quella maglia e quel periodo?
“Tanto. Sono arrivato alla Lazio da giocatore vero, da giocatore importante. Avevo giocato un Europeo, quindi anche a livello internazionale cominciavo ad avere una certa esperienza. E anche emotivamente è stata la squadra che ho sentito molto mia. Mi sono legato tanto all’ambiente, anche e soprattutto perché avevo vissuto un primo anno abbastanza travagliato. È un po’, se vogliamo fare un parallelismo, come i grandi amori: magari iniziano in maniera turbolenta, ma poi finiscono con un lieto fine. La Lazio per me è stata questo. Ho vissuto un po’ tutte le emozioni che può vivere un giocatore. L’impatto difficile, anche per una parte di contestazione, il non riuscire a esprimermi nella maniera più giusta e corretta. Dopodiché c’è stato il riscatto, la soddisfazione di aver riconquistato tutti, di essermi legato molto alla gente laziale. E poi chiudere il cerchio vincendo la Coppa Italia nel 2004, che fu la vittoria che ci ripagò di due anni molto belli con Mancini alla guida. Peccato che poi, per le vicissitudini societarie, fui quasi — tra virgolette — costretto, obbligato a lasciare la Lazio, perché non si sapeva che fine avrebbe fatto la società. Il destino mi portò a Valencia alla fine di quel campionato”.
È il 2003: Ancona-Lazio. Stam prende per il collo Parente. Cosa hai pensato in quel momento?
“Abbiamo temuto tutti quanti per Parente. Jaap era un gigante buono, noi lo definivamo così. Incuteva tanta paura, ma fondamentalmente era un ragazzo buono, vero, sincero. In campo, però, era meglio non farlo arrabbiare. Ci fu uno scontro in cui Parente lasciò la gamba su un intervento in scivolata di Jaap. E lui non era esattamente morbido in queste cose… Si rialzò e arrivarono muso a muso e per la differenza di forza, si lasciò andare a quel gesto. Lì per lì tememmo davvero. A distanza di anni, ancora oggi ci scherziamo sopra, perché c’era Parente sollevato da terra che muoveva i piedi… Sembrava in evidente difficoltà. Siamo intervenuti subito e, per fortuna, è finito tutto per il meglio”.
Con i biancocelesti ti sei tolto diverse soddisfazioni. Impossibile non citare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, decisa anche da una tua doppietta all’andata. Che emozioni hai provato in quella doppia sfida?
“Molto bello: vincere un trofeo è sempre qualcosa che rimane. Le belle partite, i bei gol, sono bellissimi ricordi, certo, ma quello che resta davvero sono le vittorie. E soprattutto le vittorie dei trofei. Per me, quella Coppa Italia ha un sapore speciale. Segnai sei gol totali tra semifinali e finali, e fui anche capocannoniere della competizione. Ho lasciato il segno in maniera molto evidente. Battere la Juventus di quegli anni non era semplice: ci riuscivano in pochi. Era una squadra fortissima, abituata a vincere. Proprio per questo, quel trofeo assume un valore ancora più prestigioso”.
In quegli anni facevi parte della cosiddetta “banda Mancini”. Che tipo di allenatore è stato per te Roberto Mancini?
“Molto importante. Arrivò il mio secondo anno alla Lazio, che — come dicevo prima — non era stato esattamente come lo avevo sognato. Il primo anno fu complicato, per tutti. I nuovi, me compreso, avevano bisogno di tempo per ambientarsi. La squadra era in difficoltà, e ne risentimmo tutti. Con l’arrivo di Mancini le cose cambiarono subito. Mi trovai benissimo con lui, c’era un grande feeling. Anche lui era agli inizi, ma riuscì a entrare in empatia con tutto il gruppo. Aveva un carisma notevole, lo stesso che aveva da giocatore: ti entrava nella testa, ti capiva. Proprio perché era stato anche lui un calciatore importante, sapeva perfettamente come ragionavamo. Ci fece giocare bene, ci dava libertà, soprattutto nella metà campo offensiva. Noi avevamo tanta qualità, e ci divertivamo davvero. La vittoria della Coppa Italia è stato il giusto premio per una squadra che ha vissuto due anni belli, in un momento societario molto difficile. Non sapevamo neanche che futuro avrebbe avuto la società, ma con lui si era creato un grande gruppo. Quella vittoria fu meritata”.
Oggi il suo nome è accostato a diverse panchine di Serie A. Dove lo vedresti bene e perché?
“Il Mister lo vedrei bene ovunque. È diventato un allenatore con una grande esperienza, ha fatto cose importantissime negli anni successivi. Io lo ritengo tra i migliori, perché ha quel qualcosa in più rispetto agli altri soprattutto come personalità, come carisma. Può stare ovunque, in qualsiasi squadra importante, in Italia o all’estero. Chi lo prende fa davvero un grande acquisto”.
La Lazio ha voltato pagina: dopo i vari addii di Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile, oggi Baroni e una squadra giovane in crescita. Che ne pensi di questa scelta e dove può arrivare questa nuova Lazio?
“All’inizio la scelta di Baroni ha generato un po’ di scetticismo: era la sua prima esperienza in un club così importante. Però io sono sempre stato positivo: se l’era meritata, ed è un allenatore che ha sempre dimostrato di valere. E infatti secondo me è andato anche oltre le aspettative. Nessuno pensava che la Lazio potesse fare questa stagione, sia in Italia che in Europa: ha fatto molto bene, e nella sfida col Bodo è mancato poco per raggiungere la semifinale. È un anno zero: sono andati via giocatori come Immobile, Felipe Anderson, Milinkovic, Luis Alberto… Giocatori che avevano fatto la storia recente della Lazio. Sostituirli non era facile. E invece sono arrivati ragazzi giovani, e anche Baroni stesso, che si sono trovati a dover reggere una piazza importante. Aver fatto una stagione così, anche in Europa, ed essere lì a giocarsi la Champions, è un risultato davvero importante. Le difficoltà potrebbero arrivare il prossimo anno, perché dovranno riconfermarsi. Ma il lavoro fatto è stato ottimo, e va sottolineato”.
Tornando alla tua carriera, qui arriva la parentesi al Valencia, inizialmente guidato da Claudio Ranieri. Cosa non ha funzionato in Spagna?
“Non lo so, è stato un anno difficile per tutti. Anche per il Mister Ranieri, che raramente si è trovato in una situazione così complicata in carriera. Forse ha sbagliato l’impostazione: ha provato a inserire troppi italiani in un gruppo che aveva appena vinto due titoli… Inserire 4-5 italiani, in quel contesto, è stato forse l’errore. Erano una squadra unita, forte e giocavano a memoria, con uno stile consolidato. Noi arrivavamo da un altro campionato. L’integrazione non fu semplice. Anche Ranieri si è trovato in difficoltà, e a gennaio arrivò l’esonero. Peccato, perché per le mie caratteristiche la Liga poteva essere un campionato perfetto”.
In passato hai dichiarato di non aver mai legato con Ranieri, con cui hai ancora “un conto in sospeso”. Ce lo racconti meglio?
“Semplicemente: quando mi convinse ad andare a Valencia, mi parlò di un progetto tecnico ben preciso. Una volta arrivato, le cose non andarono come previsto. Mi ritrovai a giocare in un ruolo dove, onestamente, c’erano interpreti più bravi di me. Così giocavo poco, e perdere il posto in Nazionale fu un colpo duro. Ci furono confronti, anche accesi, ma sempre rispettosi. Io stavo perdendo qualcosa di importante, e non ero contento neanche di come andavano le cose in squadra. Poi, proprio quando sembrava che stessi rientrando un po’ nei piani, lui venne esonerato. quindi finì così”.
Dopo Valencia, hai giocato nella Fiorentina e nel Torino: due realtà spesso messe a confronto per struttura e ambizioni. Come vedi oggi queste due squadre e fin dove possono arrivare?
“Sono due ottime realtà del nostro calcio. Salire di un gradino non è facile, perché davanti hai 5-6 squadre che per budget e qualità sono molto difficili da scalzare. La Fiorentina, rispetto al Toro, ha un presidente che ha investito tanto negli ultimi anni. E i risultati si stanno vedendo: tre finali raggiunte, ora in corsa per la quarta. Sta cercando di fare quello step in più ed è lì a giocarsi punti importanti per l’Europa. Il Toro, invece, è in quel limbo di metà classifica. Si salva sempre comodamente, ma gli manca sempre qualcosa per l’Europa. Quest’anno, ad esempio, l’assenza di Zapata ha pesato tantissimo. Chissà, con lui al 100% magari sarebbe andata diversamente. Vanoli ha fatto un buon lavoro: la squadra ha trovato una sua identità. Speriamo che possa restare per più tempo, perché sono la continuità e la programmazione che fanno la differenza. Servono due o tre anni per costruire davvero qualcosa”.
Il tuo cerchio si chiude nel 2011 a Cosenza, dove tutto era iniziato. Dopo l’addio al calcio hai vissuto un’esperienza da vice con Oddo e oggi fai coppia fissa a padel con Giannichedda. Com’è cambiata la tua vita e dove ti vedi tra 10 anni?
“Dieci anni sono tanti (ride ndr). Dopo il ritiro ho iniziato come direttore sportivo, poi — non potendolo fare con continuità — ho scelto di fare altro. Mai precludersi niente nella vita. L’esperienza con Massimo, come vice allenatore, mi ha fatto capire che preferisco l’aspetto dirigenziale. È quello il mio mondo. Mi piacerebbe avere un’opportunità per mettere a frutto questa esperienza e passione. Il padel? È una cosa goliardica, che faccio nel tempo libero con Giannichedda. Ci divertiamo, ci tiene in forma e ci fa sentire ancora un po’ atleti”.
Chiamarsi Bomber è ora su Whatsapp, iscriviti subito al canale! CLICCA QUI!